- Home
- Libri
- Collane
- Autori
- Prossime Uscite
- News
- Nuovi talenti
- Blog
- Acquisti
- Home
- Libri
- Collane
- Autori
- Prossime Uscite
- News
- Nuovi talenti
- Blog
- Acquisti
0
Le Poesie di Živago ripercorrono l’intera vicenda di Jurij, protagonista del romanzo Il dottor Živago, facendo da riassunto per “tappe” del suo percorso esistenziale. Jurij Živago è la trasposizione romanzata, l’alter ego di Pasternak. Si fa interprete di quella stessa fragilità dell’individuo e di quella solitudine dell’intellettuale che Pasternak sperimenta nella sua esistenza dentro la violenta morsa della storia del suo paese “stravolto e squartato” dalla guerra e dalla rivoluzione. Si fa portavoce di quella stessa alternativa spiritualistica impregnata di sensibilità cristiana di cui Pasternak è stato testimone coraggioso nella sua vita. Dietro alla sua creatività e all’esercizio del pensiero, Jurij nel romanzo scrive e pubblica poesie proprio come fa lo stesso Pasternak nella vita reale. E Jurij nel romanzo vive lo stesso dissidio del suo autore tra l’artista e la società, tra la poesia e la politica, tra l’arte e la storia, tra l’amore e il matrimonio. Le Poesie di Živago si segnalano per le atmosfere intime e personalissime, prive di qualsiasi accento declamatorio, con cui Pasternak tratta il tema della patria sofferente, e per lo “scintillante mosaico di immagini” attraverso cui parla d’amore, di illusioni e delusioni, di insoddisfazione personale, di ansia religiosa, di ricerca spirituale.
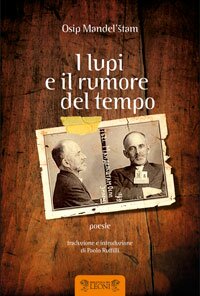
Mandel’štam ha scritto alcune delle poesie più dure nei confronti della “follia sovietica”, sino alla famosa invettiva contro Stalin, una sorta di autocondanna capitale che lo ha portato alla denuncia e all’arresto e a quel calvario di prigione, confino, lager, durato cinque anni fino alla morte.
Mandel’štam ha scritto alcune delle poesie più dure nei confronti della “follia sovietica”, sino alla famosa invettiva contro Stalin, una sorta di autocondanna capitale che lo ha portato alla denuncia e all’arresto e a quel calvario di prigione, confino, lager, durato cinque anni fino alla morte, costretto a vivere degli aiuti degli amici insieme alla moglie Nadežda in mezzo ai lupi e al rumore del suo tempo. In tutta la sua produzione intensamente lirica, per Mandel’štam la parola della poesia doveva per forza avere una valenza integrale per l’istintivo rigetto del luogo comune, dell’immagine inerte, del tono ingessato, della frase fossilizzata. Decisiva era per Mandel’štam la musica della parola, ciò che rende impossibile fino in fondo una traduzione dei suoi versi, ma che stimola Paolo Ruffilli a confrontarsi con la sua poesia tentando comunque di renderne in un’altra lingua le profonde suggestioni. Mandel’štam Osip
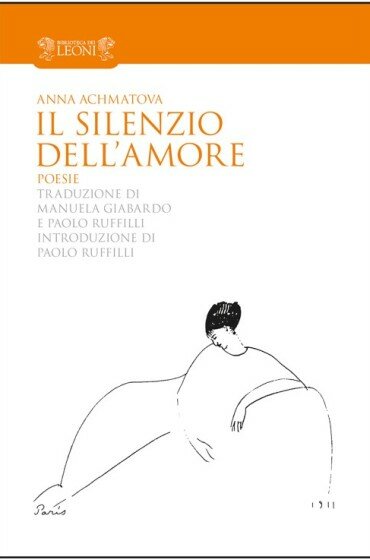
La Achmatova fu subito apprezzata poiché i suoi versi trattano dell’amore in un lungo e frammentario memoriale della passione, in cui la poesia è fedele alle glorie e alle debolezze della propria condizione di donna, alle luci e alle ombre della propria personalità accettata in tutto e per tutto.
La Achmatova fu subito apprezzata poiché i suoi versi trattano dell’amore in un lungo e frammentario memoriale della passione, in cui la poesia è fedele alle glorie e alle debolezze della propria condizione di donna, alle luci e alle ombre della propria personalità accettata in tutto e per tutto. Ed è la ragione per cui le immagini di quell’amante libera e capricciosa che è Anna non sono mai folli o frenetiche, ma femminili e domestiche e la sua arte ignora il senso tragico e dionisiaco dell’amore. Perché, come ripete lei stessa, “l’amore è bello e terribile proprio perché è una cosa di tutti i giorni, la più dolce delle abitudini, un eterno presente” e appartiene non alla storia, ma alla cronaca della vita. Interprete non solo dell’amore, ma anche delle vicende tragiche delle guerre e delle sofferenze delle grandi purghe staliniane dopo la Rivoluzione, “Anna di tutte le Russie”, come la chiamava Marina Cvetaeva, è universalmente nota per essere diventata la “voce” stessa del popolo russo, testimone e custode del destino del suo paese.
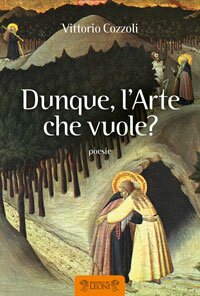
La proposta di queste pagine è una ricerca che invita, “nell’aria che, anche da lontano, già profuma,” a trovare la risposta alla grande domanda: Dunque, l’arte che vuole? Vittorio Cozzoli si pone la questione e propone la sua risposta per fede e convinzione intellettuale.
La proposta di queste pagine è una ricerca che invita, “nell’aria che, anche da lontano, già profuma,” a trovare la risposta alla grande domanda: Dunque, l’arte che vuole? Vittorio Cozzoli si pone la questione e propone la sua risposta per fede e convinzione intellettuale. L’Italia di oggi ha bisogno di poesia ‘nuova’: quella che spesso si legge è poca cosa perché sembra poca cosa quello in cui chi scrive crede, “ormai neppure più negativo o negatore, ma nella sua sostanza indifferente”. Anche dal punto di vista della lingua, fatta scendere spesso sotto il livello di guardia. Occorrono esempi alti, anche stilisticamente, perché lo stile è segno di qualità-non-retorica. Occorre resistere ad un minimalismo della quotidianità che non vede più in là del proprio naso e “avere coraggio profetico, ricordare che la poesia ha radici che la lingua stessa non può più a lungo emarginare o ignorare.
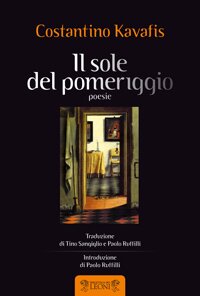
Costantino Kavafis si è ispirato al mondo ellenistico pagano che ad Alessandria, sua città natale e in quegli anni ombelico del mondo, celebrava gli ultimi fasti.
Costantino Kavafis si è ispirato al mondo ellenistico pagano che ad Alessandria, sua città natale e in quegli anni ombelico del mondo, celebrava gli ultimi fasti. Eccoli, i motivi ricorrenti: l’amore (vissuto tra sensualità violenta e accorata nostalgia), l’inafferrabilità della bellezza (specchio del desiderio che non si placa), la storia (vista come terreno di scontro tra l’uomo e la sorte).